Oggi arriviamo a una versione della più famosa delle dimostrazioni di inesistenza di dio, quella che ha ispirato per millenni eserciti di apologeti a cercare di arrovellarsi in labirinti retorici per ignorarne l’ovvia conseguenza: il problema del male.
Specificamente nella forma del problema della sofferenza.
E vedremo come non solo non è affatto stato smentito filosoficamente ed è più vivo che mai, ma come possiamo dimostrarlo con logica formale a partire solo da fatti empirici oggi indubitabili e attributi divini basilari (considerati per altro dogmi della chiesa cattolica). Nel corso di questa dimostrazione vedremo per altro come ogni sofferenza è del tutto non necessaria, dalla più piccola alla più grande.
Premettiamo che fare una trattazione davvero completa del problema è impossibile. La vastità del soggetto è a questo punto tale da richiedere ore solo per fare un’introduzione elencando le questioni principali a riguardo. Non esagero, eccovene una, fatta da uno dei migliori divulgatori filosofici che conosco:
E in due ore e rotti anche loro chiariscono che non hanno pretesa di completezza.
Come approfondimento pure ogni pretesa di completezza è impossibile: qui ho trattato il solo problema logico del male per un paio d’ore, grattando appena la superficie della cosa:
Quindi in partenza abbandono ogni voglia di farvi una panoramica e mi concentro solo su una particolare nicchia, quella che mi interessa di più per questa serie: il problema logico. Ovvero proprio l’asserzione che dio e il male non possono coesistere in alcun mondo possibile. E in una forma particolare, trattando specificamente della sofferenza e non altri tipi di male.
In altre parole qui dimostreremo che un dio onnipotente e onnibenevolente non può esistere perché:
- la sofferenza esiste
- un dio onnipotente e onnibenevolente può e vuole eliminarla
- queste cose si contraddicono
Questo ovviamente richiede che definiamo i termini, perché se per sofferenza intendiamo l’esistere separati da dio, e il dio in questione ha tutta l’onnipotenza del sasso (potere ciò che è in accordo con la propria natura), certo che possono esserci mondi in cui uno è separato da un dio non onnipresente e con quell’onnipotenza.
Per il potere di creation-skull

Per oggi ci sono cruciali due aspetti di dio: la sua onnipotenza e la sua onnibenevolenza. Entrando più in dettaglio, che concezioni di onnipotenza e onnibenevolenza ci interessano?
Della onnipotenza divina ci interessano due capacità in particolare:
- quella di creare o meno ogni umano, indipendentemente quindi dall’ipotesi di un atto creativo nella sua interezza (globalità dell’Universo), oppure riferita alla creazione di ogni singolo essere umano, presunta anima compresa.
- quella di intervenire sul moto browniano delle molecole, dirigendo (provvidenzialmente o miracolosamente) queste ultime in una particolare direzione.
Ora, per quanto di norma non si esprimano dogmi in termini di molecole, le visioni di dio che non sono dotate di questi poteri sono estremamente marginali.
Partiamo con l’esame di questi aspetti dell’onnipotenza secondo il cattolicesimo:
- Il sinodo di Sens del 1140 condannò gli errori di Pietro Abelardo, incluso “Dio non deve e
non può impedire il male“, è cioè da eretici affermare che dio non possa impedire la sofferenza. - Il Concilio vaticano I, 1869-1870, nella costituzione dogmatica Dei Filius (fonte), stabilisce per
dogma che dio ha fatto la sua creazione con “la più libera delle decisioni” (liberrimo, nel latino del testo) e nei suoi i canoni dogmatici, (1.5 in particolare, la parte contro i güntheriani) si proclama anatema se qualcuno “dice che dio le ha create non con una volontà libera da ogni necessità, ma tanto necessariamente quanto necessariamente ama sé stesso”. - La libertà di creare o non creare è ribadita dal Catechismo (ccc. 317).
Alla luce dei punti sopra possiamo concludere quanto segue: sia in maniera affermativa che in maniera negativa il buon cattolico è costretto a sostenere la verità della libertà di dio di creare o non creare.
In aggiunta la commissione teologica internazionale in “Comunione e servizio: la persona umana creata a immagine di dio” dice “La dottrina della creazione immediata o speciale di ogni singola anima umana non solo affronta la discontinuità ontologica tra materia e spirito, ma getta anche le basi per una divina intimità che abbraccia ogni singola persona umana sin dal primo momento della sua esistenza.” (fonte) Chiarisce così che ogni singola anima è un atto di creazione diretta e libera di dio. La cosa è biblicamente affermata in Apocalisse 4:11 (Bibbia CEI, ed. 2008, fonte) “Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l’onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà esistevano e furono create” e ancora Zaccaria 12:1 (stessa edizione, fonte) “Oracolo del Signore che ha dispiegato i cieli e fondato la terra, che ha formato il soffio vitale nell’intimo dell’uomo”.
Infine, sul moto browniano, questo rientra tra le facoltà divine sancite a mezzo di dogma nel novero della provvidenza divina: “Iddio, con la Sua provvidenza, conserva e governa tutte le cose che Egli ha creato, estendendosi da un confine all’altro con forza, e disponendo soavemente ogni cosa (Sap 8,1).” e anche “1. Se qualcuno negherà l’unico vero Dio Creatore e Signore di tutte le cose visibili ed invisibili: sia anatema.” (fonte).
Biblicamente parlando, si può citare il Salmo 135:6 (Bibbia CEI, ed. 2008 fonte) “Tutto ciò che vuole il Signore lo compie in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi.”
Anche nell’Islam sembra che valgano queste facoltà, “117. Egli è il Creatore dei cieli e della terra; quando vuole una cosa, dice «Sii» ed essa è.” (fonte) In particolare in base a una dottrina chiamata Tawḥīd al-Rubūbiyyah (approfondimento).
E in generale, credo sia raro trovare un credente disposto a negare il motto popolare secondo cui “non si muove foglia che dio non voglia“.
Perché dio ti ama non-consensualmente
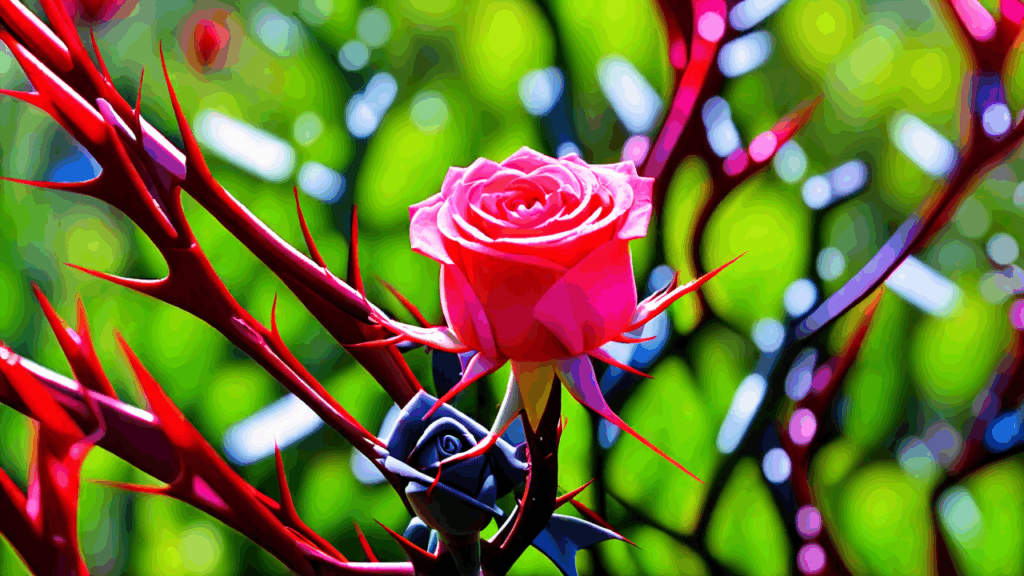
Innanzitutto un piccolo inciso: deontologicamente parlando, non sta a dio, ma a noi decidere della nostra sofferenza. Un dio che scegliesse di farci soffrire un po’ oggi per farci stare meglio domani, dovrebbe chiedere a noi se siamo disposti a farlo, non imporci questa scelta. Se lo fa per amore, è un amore non consensuale e quindi non amore. Quindi già questo basterebbe a squalificare qualsiasi dio amorevole dalla presenza della sofferenza.
Ma passando a definire l’onnibenevolenza, la questione si complica un filo. Il termine è fin troppo interpretabile, anche più che “onnipotente”.
Il concetto di “benevolenza” ossia di “volere il bene” è vago per via della difficoltà di definizione in teologia del termine “bene“. È un termine sul quale i teologi hanno fatto deliri pindarici e voli mistici, scritto tutto e il contrario di tutto, attribuendo al concetto modelli in cui ha una natura ontologica e trascendente in alcuni casi, in cui è una sorta di quintessenza divina in altri, in cui è un qualcosa di definito arbitrariamente da dio in altri ancora. Questo per non aprire il problema etico e meta-etico delle concezioni di bene (chi vuole può ripassare qui la vastità della questione).
Quindi ancora una volta eviterò anche il solo tentativo di presentare appieno l’argomento; indicherò quali caratteristiche specifiche ci interessano nella dimostrazione in questione, e i teologi saranno poi liberi di abbandonare immediatamente ogni dottrina che difendevano a spada tratta fino a un minuto prima in uno spostamento carpiato del traguardo.
Saranno liberi di rinnegare il Catechismo della chiesa cattolica. 321 che rimarca come “La divina Provvidenza consiste nelle disposizioni di Dio, con sapienza e amore“. Liberi di dare alle fiamme la Summa contra gentiles, libro 3, cap. 90.5 dove l’Aquinate dichiara che “il governo della Provvidenza deriva dall’amore col quale dio ama le cose da lui create: infatti l’amore consiste specialmente nel fatto che «chi ama vuole del bene all’amato»”. E liberi pure di rinnegare il Concilio Vaticano II, che nella Gaudium et spes recita “l’uomo, il quale in terra è la sola creatura che Iddio abbia voluto per se stesso” e che “il disegno di dio e la sua volontà corrispondono al vero bene dell’umanità“. Non saranno però liberi, se vogliono restare cattolici, di rinnegare la costituzione dogmatica Dei Filius del Concilio Vaticano I dove si recita “dio, con la sua provvidenza, protegge e governa tutto ciò che ha creato” (fonte). Non saranno liberi, se vogliono restare cristiani, di ignorare 2 Corinzi 3-4 e la sua indicazione della volontà divina di lenire l’umana sofferenza, o l’esplicita indicazione di preferenza resa in Lamentazioni 3:33 “Poiché contro il suo desiderio egli [dio] umilia e affligge i figli dell’uomo.”
Quello che ci interessa qui per parlare di benevolenza è infatti semplicemente il desiderio di evitare la sofferenza umana, a parità di tutto il resto.
Sottolineo l’ultima locuzione perché è cruciale: a parità di tutto il resto, ovvero stiamo dicendo che qualora non cambi assolutamente nulla di nulla in qualsiasi altro aspetto, là dove fosse possibile distinguere due situazioni tra loro unicamente per una maggior sofferenza in una delle situazioni, dio dovrebbe desiderare l’altra, quella con minor sofferenza, per essere definito benevolente.
L’alternativa è che dio non abbia o alcuna preferenza in materia, quindi che sia un dio indifferente alla sofferenza umana, o che dio preferisca la maggior sofferenza a parità tutto il resto, risultando quindi un dio sadico.
Per dirla in termini matematici, definite
S(x) = sofferenza nella situazione x
P(x) = preferenza che dio ha per la situazione x
date le situazioni x1 e x2, che hanno come UNICA differenza che S(x1)>S(x2)
Definiremo:
- benevolente un dio per il quale P(x1) < P(x2)
- malevolo (o sadico) un dio per il quale P(x1) > P(x2)
- e indifferente un dio che non rientra in questi due casi
Quindi diventa evidente che un dio amorevole (benevolente) e non malevolo o indifferente è un dio che necessariamente cerca di minimizzare la sofferenza. Ovvero che ogni volta che gli è possibile evitare una sofferenza a parità di tutto il resto, farà sempre quella cosa che gli è possibile per evitarla. In altre parole questo ci permette di stabilire un principio: che qualora esista qualcuno che minimizza la sofferenza a parità di tutto il resto, allora se è possibile non averne, non ne avremo affatto. Necessariamente.
Va notato che normalmente il discorso sulle varie teodicee non discute questo e non tratta delle situazioni “a parità di tutto il resto”, perché i nessi causali vengono dati per scontati e si presume che in qualche modo a dio sia imposto di scegliere tra la presenza della sofferenza e un qualche tipo di “bene superiore” che la necessita, rendendola inevitabile, in una qualche maniera.
Ecco, invece ora dimostreremo che niente e nessuno necessita una sofferenza. Mai. E quindi che tutta la sofferenza è sempre evitabile a parità di tutto il resto.
La chiudo e la faccio saltare

Ed eccoci qua al pezzo forte di questo articolo. Siamo all’undercutting defeater, l’argomento mooriano, l’evidenza che elimina alla radice ogni possibile teodicea per questo problema: dimostrare che letteralmente ogni sofferenza non è né necessaria né necessitata.
Questa dimostrazione si compone di 3 parti. Da un lato dimostriamo che in assoluto non c’è necessità della sofferenza. Ovvero che la sofferenza di per sé non è un qualcosa che necessariamente succede (e quindi è possibile, contingente).
Dall’altro che la sofferenza non è necessitata da qualcos’altro, né per modus ponens né per modus tollens. Ovvero che non può essere considerata necessaria né perché implicata (effetto), di qualcosa d’altro, né perché un qualche effetto la necessita come sua causa.
Della prima parte vedremo più avanti una dimostrazione in logica formale (assieme al resto della dimostrazione logica di inesistenza) che parte dall’onnipotenza.
L’intuizione fondamentale è che essendo dio libero di non creare, ed essendo la sofferenza qualcosa che esiste solo nel creato, ne segue che la sofferenza avrebbe potuto non esistere e quindi non è necessariamente esistente.
Ora occupiamoci delle altre due: la sua non necessità come effetto e quella come causa.
La sofferenza in senso neuroscientifico
Prima di chiarire questi aspetti logici, bisogna ricordare che cosa è la sofferenza con estrema precisione. Questa ad esempio va distinta dalla nocicezione (o dolore), ovvero dal meccanismo per il quale il nostro corpo ma non la nostra mente riconosce la presenza di un danno. Questa distinzione per altro è stata spesso usata dagli apologeti per difendere dio dall’accusa di aver fatto soffrire gli animali non umani, sostenendo che i loro cervelli non fossero in grado di una vera percezione della sofferenza, ma solo di una nocicezione. E ovviamente è un errore fatto e finito, anche gli altri animali soffrono.
Quando infatti un corpo subisce un danno come ad esempio durante un’ ustione o un taglio, ci sono precisi sistemi sensoriali che lo rilevano e attivano degli specifici neuroni, ad esempio al livello della pelle, chiamati appunto nocicettori. Questi neuroni trasmettono un impulso non direttamente e immediatamente al cervello, ma prima fino al midollo spinale il quale a volte determina una reazione immediata.
Quando per esempio si mette una mano su una pentola troppo calda e la si lascia andare immediatamente senza nemmeno il tempo di accorgersi di cosa stava succedendo “di riflesso”, quel che è accaduto è proprio che la reazione è partita non dal cervello ma dal midollo spinale.
Quando poi il segnale del dolore raggiunge il cervello e viene elaborato dai neuroni lì presenti e integrato nella nostra coscienza, allora ne facciamo esperienza cosciente e proviamo la sofferenza nel senso inteso ai fini di questa dimostrazione.
Gratuità come effetto
Sofferenza e dolore quindi sono basate su reazioni chimiche che richiedono una serie di presupposti per accadere, alcuni dei quali governati da sistemi caotici.
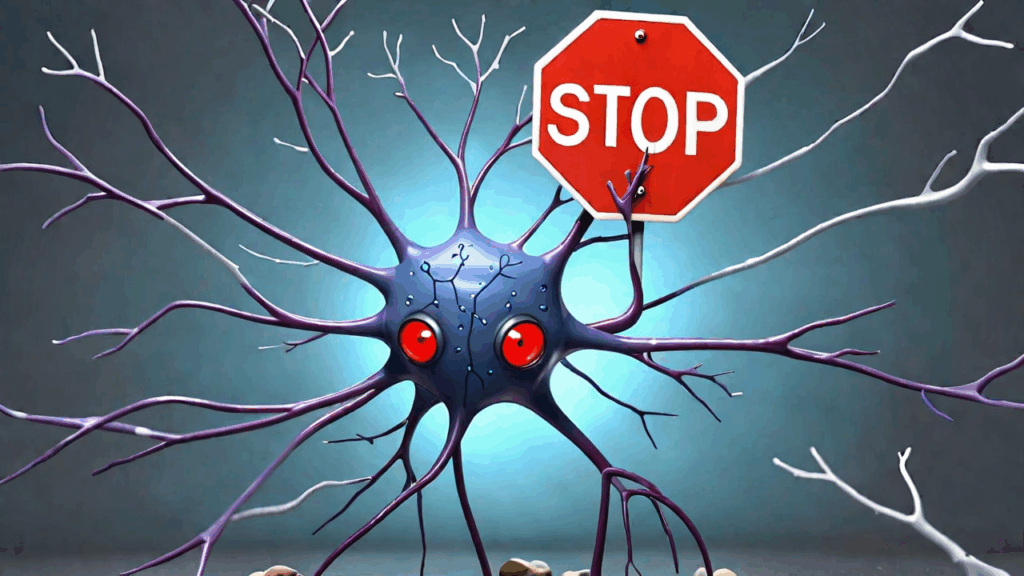
Un esempio cruciale per noi oggi è la trasmissione del segnale del dolore da un neurone all’altro. Questo avviene quando il neurone che trasmette il segnale rilascia delle molecole dette neurotrasmettitori in un punto di contatto (sinapsi) con il neurone ricevente. Questi neurotrasmettitori si spostano usando un moto browniano, ovvero una diffusione casuale.
In pratica è come se il neurone trasmittente spruzzasse un profumo davanti al naso di quello ricevente. Per una descrizione tecnica vedasi questa fonte.
Questo meccanismo di trasmissione però non garantisce affatto che ogni singola molecola raggiunga un recettore. Statisticamente, in media, questo meccanismo di trasmissione è affidabile, ma eccezioni sono possibili. Non c’è quindi alcuna necessità logica che questo meccanismo riesca a trasmettere l’informazione e quindi che la percezione del dolore funzioni.
Per fare un’analogia, immaginate di spruzzare del profumo vicino al vostro naso, ma durante un uragano. I fortissimi venti spazzano via ogni molecola della fragranza prima che vi arrivi al naso. Ecco, per la singola molecola non serve che ci sia un forte vento, basta che abbia sfortuna nell’urtare con le molecole d’aria attorno alla boccetta e finisce per disperdersi nell’ambiente senza che venga recepita. Questo significa che per ogni singola molecola non è vero che debba necessariamente arrivare a destinazione.
Per sostenere che questo non sia vero bisognerebbe innanzitutto asserire che ogni singolo neurotrasmettitore necessariamente giunga sempre a destinazione (cosa empiricamente falsa) ma anche che il dio che può sollevare un vento per dare un suo segno, poi non può muovere molecole in quantità molto minore di una distanza molto minore.
Sia chiaro che questo non violerebbe il libero arbitrio: non si tratta di costringere nessuno a fare alcunché o a volere alcunché, ma solo di impedire (o attenuare) una percezione (come nell’episodio biblico in cui Pietro esce dalla prigione senza che nessuna guardia possa vederlo in atti 12 ( fonte ) o nella favoletta miracolistica in cui Bernadette a Lourdes non sentiva dolore nonostante avesse una mano sulla fiamma di una candela ( fonte prima che la smentisce)).
Se poi si abbandona l’ipotesi dell’identità mente-cervello è ancor più gratuito che uno stato fisico del cervello debba corrispondere a un qualsiasi stato mentale, men che meno necessario che tali corrispondenze siano mediate da leggi o meccanismi di sorta.
Non solo, abbiamo esempi di sofferenza priva di cause esterne. Sindromi come l’arto fantasma (una condizione in cui si ha la percezione della presenza un arto che è stato amputato) e in particolare dolori cronici ad arti fantasma indicano come si possa arrivare a soffrire senza che vi sia altra causa che una attivazione di neuroni.
In altre parole nonostante la forte correlazione statistica e l’evidente nesso causale, si può dire che la sofferenza non ha né una causa sufficiente né una causa necessaria in alcun evento esteriore all’individuo. Ciò comporta che in ogni caso si possa parlare, da un punto di vista logico, di una condizione di possibilità e contingenza, mai di necessità. In altre parole in ogni istanza la sofferenza come effetto è evitabile. Ovvero è sempre possibile evitare la sofferenza in ogni caso specifico, indipendentemente dalla causa. È solo inatteso che questo avvenga nella maggioranza dei casi sotto un modello fisicalista.
Gratuità come causa
Dal punto di vista degli effetti del dolore, ne abbiamo due possibili : fisiologici e psicologici.
Per quanto riguarda gli effetti fisiologici spesso questi non dipendono direttamente dalla percezione del dolore, ma solo dalla nocicezione, possono occorrere infatti anche in pazienti in anestesia completa durante una operazione chirurgica (fonte).
Ciò comporta che almeno alcuni degli effetti fisiologici associati al dolore non necessitano di una sofferenza come causa. E se questo è possibile per alcuni, non c’è vincolo che avrebbe impedito di avere una struttura neurale per la quale ogni effetto fisiologico della sofferenza fosse invece solo collegato alla nocicezione.
Riguardo quelli psicologici, la dottrina del libero arbitrio impone che questi non possano essere una forza che costringe l’uomo a fare alcunché. La psiche umana in questo senso è fuori dai limiti delle catene causali di cui il teista può fare uso. In altre parole chi crede al libero arbitrio deve necessariamente rigettare un ruolo causale al dolore, o altrimenti sarà costretto ad ammettere che le decisioni e gli atti umani sono essi stessi effetti di una catena causale e in quanto tale moralmente imputabili a ciò che con un atto di libertà avesse messo in atto tale catena.
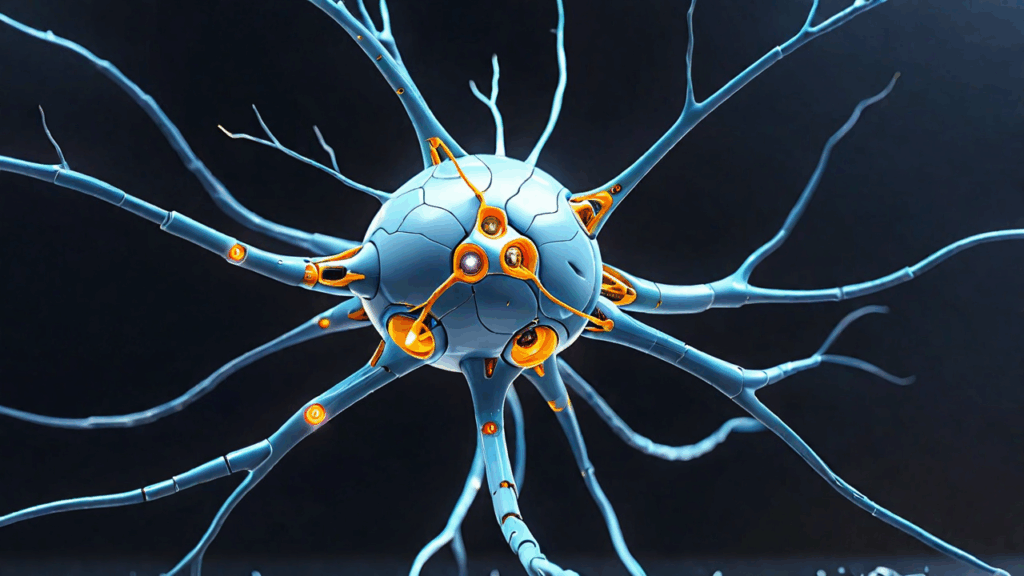
Ignorando poi il libero arbitrio e concentrandoci solo sulla chimica del cervello, abbiamo che ogni meccanismo psicologico è comunque mediato dalla attivazione di neuroni, la quale, a sua volta, dipende dalla differenza di potenziale elettrico tra interno ed esterno della membrana dei neuroni (fonte). Tale differenza è data dalla concentrazione di ioni all’interno del neurone rispetto a quella al suo esterno. Tuttavia va notato che questa concentrazione è rilevata da specifici recettori sulla membrana che hanno la capacità di far partire una reazione a catena per la quale se un singolo recettore scatta, mette in moto una catena di eventi che attiva l’intero neurone. Quindi è sufficiente che anche momentaneamente una concentrazione di ioni adatta si verifichi in prossimità di un recettore perché questo scatti provocando l’attivazione di quel neurone.
E come si muovono questi ioni? Sempre di moto browniano nel citoplasma del neurone. Anche in questo caso, quindi, se manteniamo la teoria dell’identità mente-cervello possiamo dire che non è logicamente necessario alcuno stato mentale particolare per provocare l’attivazione di un singolo neurone. E quindi, ancora, che non è necessario alcuno stato psicologico precedente perché si giunga a uno stato psicologico successivo. Ovviamente questo tipo di salto sarebbe estremamente improbabile. Ma oggi ci interessa la possibilità logica, non quello che è probabile.
Da questo consegue che anche dal punto di vista degli effetti il dolore appare del tutto gratuito per il teista, cui questa dimostrazione si rivolge.
Gli effetti quindi o possono essere ottenuti senza sofferenza o addirittura non sono neppure riconosciuti come causalmente collegati al dolore. Quindi detti effetti non possono necessitare la sofferenza o perché questa non è necessaria per la loro esistenza o perché addirittura non ne era la causa in primo luogo.
Insomma, la sofferenza è gratis, prendetene a piacere

Essendo la sofferenza sempre e solo possibile effetto, mai necessario, ed essendo i suoi effetti sempre ottenibili in sua assenza, risulta che non c’è né causa necessaria né sufficiente, né per modus ponens né per modus tollens, della sofferenza. Ogni causa e ogni effetto possono manifestarsi, logicamente, anche in assenza di sofferenza.
Non essendo la sofferenza causa necessaria di alcun effetto essa non può essere necessitata nemmeno strumentalmente, sarebbe a dire che non può essere necessaria nemmeno a un ipotetico secondo fine. Ciò significa che è possibile avere tutto il resto anche senza la sofferenza.
Questo ci porta inevitabilmente a concludere che essa non può in nessun caso essere considerata altro che una possibile contingenza. Insomma che ogni istanza di sofferenza in linea di principio avrebbe potuto essere evitata a parità di tutto il resto.
Questo criterio, in particolare, previene la risposta dalla dottrina dei duplici effetti, dove una singola causa può avere sia effetti positivi che effetti negativi e quindi essere giustificata dal bilancio tra questi. Previene altresì ogni teodicea dei “beni superiori” nonché ogni appello al mistero della fede: non c’è incertezza residua in cui si possa nascondere una misteriosa ragione divina per la sofferenza. Siamo certi che se la sofferenza è lì, è perché è proprio la sofferenza a esser stata messa apposta o lasciata con noncuranza da un dio sadico o indifferente.
Formuliamo la dimostrazione
Ricapitolando, la nostra tesi è che un dio onnipotente e onnibenevolente o che ama tutti non può esistere perché:
- la sofferenza esiste pur essendo non necessaria in assoluto, non necessitata né come premessa né come conclusione
- ma un omni-dio simile può e vuole eliminarla
- queste cose si contraddicono
In particolare una volta dimostrato che la sofferenza può sempre essere evitata a parità di tutto il resto, la conclusione dovrebbe essere ovvia: un dio capace di evitarla e che vuole evitarla non potrebbe che evitarla.
E in particolare è del tutto impossibile che ci sia una qualche ragione nascosta che lo spinga a non evitarla dato che può essere evitata a parità di tutto il resto, inclusa quella ragione. Se questo non avviene significa che un dio così non esiste.
Ma andiamo, finalmente alla dimostrazione logica formale.
Definiamo innanzitutto i seguenti predicati:
Soffre(x) = “x ha esperito sofferenza”, di seguito per brevità “x soffre”
O(x) = “x è onnipotente”
AL(x) = “x è onnibenevolente”
Crea(x,y) = “x è il creatore di y”, di seguito per per brevità “x crea y”
MinimizzaSofferenza(x) = “x minimizza la sofferenza”
Anestetizza(x,y) = “x impedisce la sofferenza di y”
E andiamo ad affrontare la dimostrazione, le premesse sono che:
- ∀x( ( AL(x) ∧ O(x) ∧ ◇∀y(¬Soffre(y)) ) → □∀y(¬Soffre(y)) ) – (per ogni x, se x è onnibenevolente e onnipotente ed è possibile che ogni y non soffra, allora è necessario che ogni y non soffra; ipotesi di minimizzazione della sofferenza, questa particolare formulazione è dimostrata a sua volta nel paragrafo “Benevolo, indifferente o sadico”, NB: questa premessa qualifica come “problema logico” questa dimostrazione)
- ∀x∀y( O(x) → ◇(¬Soffre(y)) ) – (per ogni x e ogni y, se x è onnipotente allora è possibile che y non soffra; ipotesi che l’onnipotenza includa la capacità di non far soffrire, vedi i paragrafi “perché dio ti ama non-consensualmente” e la successiva dimostrazione al paragrafo “Dio come anestetico”)
- O(d) ∧ AL(d) – (dio è onnipotente e onnibenevolente; ipotesi sulla natura di dio di onnibenevolenza e onnipotenza)
- Soffre(p) – (p soffre; ipotesi che una persona p ha esperito sofferenza, la quale ricordiamo è sempre logicamente evitabile in tutte le sue istanze)
Quindi i passaggi deduttivi:
- O(d) – (dio é onnipotente, da 3 per eliminaz. della congiunzione; se dio è sia onnipotente che onnibenevolente, si può dire che sia onnipotente )
- ∀y( O(d)→ ◇ ¬Soffre(y) ) – (per ogni y se dio è onnipotente allora è possibile che y non soffra, da 2 per eliminaz. del quantificatore universale x; se è vero che per ogni ente la sua onnipotenza rende possibile la non sofferenza di un qualsiasi y, a maggior ragione è vero che per dio la sua onnipotenza rende possibile la non sofferenza di un qualsiasi y)
- O(d)→ ◇( ¬Soffre(p) ) – (se dio è onnipotente, allora è possibile che p non soffra, da 6 per eliminaz. del quantificatore universale y; se dio può non far soffrire un qualsiasi y, questo vale anche per p specificamente)
- ◇¬Soffre(p) – (è possibile che p non soffra , da 5,7 per modus ponens; se l’onnipotenza di dio implica la possibile non sofferenza di p e dio è onnipotente, allora ne deduciamo che è possibile che p non soffra )
- ( AL(d) ∧ O(d) ∧ ◇∀y(¬Soffre(y)) ) → □∀y(¬Soffre(y)) – (* se dio è onnibenevolente e onnipotente ed è possibile per ogni y che y non soffra, allora necessariamente per ogni y questo non soffre, da 1 per eliminaz. del quantificatore universale x*; anche qui abbiamo preso un’affermazione valida per ogni x e l’abbiamo applicata al caso specifico di dio)
- ( AL(d) ∧ O(d) ∧ ◇(¬Soffre(p)) ) → □(¬Soffre(p)) – (se dio è onnibenevolente e onnipotente ed è possibile che p non soffra, allora necessariamente p non soffre, da 9 per eliminaz. del quantificatore universale y; anche qui prendiamo quel che si è detto al rigo prima per ogni soggetto e lo si applica al caso specifico di p)
- AL(d) ∧ O(d) ∧ ◇(¬Soffre(p)) – (dio è onnibenevolente e onnipotente ed è possibile che p non soffra, da 3,8 per introduzione congiunzione; visto che in precedenza abbiamo già stabilito per premessa e dalla deduzione sia che dio è onnibenevolente e onnipotente e che è possibile che p non soffra, uniamo queste affermazioni in una congiunzione che le include tutte e tre)
- □(¬Soffre(p)) – (necessariamente p non soffre, da 10,11 per modus ponens; avendo stabilito che se dio è onnibenevolente e onnipotente ed è possibile che p non soffra, allora necessariamente p non soffre e che la premessa di questa implicazione è vera, ne segue la conclusione, ovvero che la non sofferenza di p è necessariamente vera)
- ¬Soffre(p) – (*p non soffre, da 12 per necessità implica verità, assioma della logica modale M in notaz. della plato stanford encyclopedia, T in quella di wikipedia *; se è necessariamente vero che p non soffre, è anche vero che p non soffre)
- ⊥ – (contraddizione, da 4,13; Come volevasi dimostrare, abbiamo sia affermato per vero che p soffre sia che p non soffre, giungendo quindi a una contraddizione)
La dimostrazione di cui sopra prova che le premesse sono incompatibili tra loro. Una premessa indiscutibile è la 4, ovvero che p soffra. Chiunque abbia mai esperito sofferenza sa che c’è almeno una persona che ha esperito sofferenza, egli stesso. Siamo quindi tutti testimoni in maniera diretta della verità di questa premessa.
Siamo tutti p.

La premessa 3 è quella di onnipotenza e onnibenevolenza divina, negata la quale stiamo a tutti gli effetti affermando l’inesistenza di questo tipo di dio.
Restano quindi le prime due proposizioni al teista che volesse evitare l’apostasia come terreno di caccia per una scappatoia, ma come vedremo a breve, anche lì non c’è speranza.
Dio come anestetico
A questo punto concentriamoci sulla premessa che l’onnipotenza renda possibile che non ci sia sofferenza.
Nei paragrafi precedenti (vedi “Per il potere di creation-skull” e “La chiudo e la faccio saltare”), abbiamo constatato che i cattolici per dogma devono credere a questa asserzione, vista la facoltà di dio di non creare gli esseri umani singolarmente e la creazione in toto, che buona parte dei musulmani hanno similari vincoli teologici e che in ogni caso a meno di negare a dio la facoltà di muovere qualche molecola di qualche decimo di millimetro, la sofferenza resta del tutto contingente.
Ora però arriveremo a difendere questa proposizione anche con una dimostrazione logica, in due versioni.
Basata sulla facoltà di non creare
Questa versione parte dal dogma della libera creazione, che quindi qualifica dio come capace di non creare le persone che poi andrebbero a soffrire. Da questa prospettiva arriveremo a dimostrare che la sua onnipotenza rende possibile l’assenza di sofferenza.
premesse:
- O(d) – (dio è onnipotente; sub hypothesis, stiamo cercando di dimostrare che da questa premessa si arriva a una conclusione, quindi è assunto come premessa)
- ∀y( O(d)→ ◇¬Crea(d,y) ) – (per ogni y, se dio è onnipotente allora è possibile che dio non crei y; premessa che la creazione di dio è libera e non necessaria, dogma per i cattolici)
- ∀y( ¬◇¬Soffre(y) → □Soffre(y) ) – (per ogni y, se non è possibile che y non abbia esperito sofferenza allora necessariamente y ha esperito sofferenza; effettivamente stiamo solo applicando una regola della logica modale, valida in ogni logica modale, che ¬◇¬ uguale □ al caso della sofferenza)
- ∀y( □Soffre(y) → □Crea(d,y) ) – (per ogni y se necessariamente y ha esperito sofferenza allora necessariamente dio ha creato y; premessa che non esistano creatori all’infuori di dio, e quindi che se y soffre necessariamente, deve necessariamente essere stato creato, per negare questa bisogna dire che si può soffrire senza essere stati creati)
deduzioni
- O(d)→◇¬Crea(d,p) – (se dio è onnipotente, allora dio può non creare la persona p, da 2 per eliminaz. del quantificatore universale su y; se è vero per ogni creatura che dio se è onnipotente allora può non crearla, sarà ben vero anche per p)
- ◇¬Crea(d,p) – (possibilmente dio non crea p, da 1,5 per modus ponens; dato che l’onnipotenza di dio implica la sua facoltà di non creare e che abbiamo assunto detta onnipotenza per ipotesi, concludiamo che dio può non creare p)
- ¬¬◇¬ Crea(d,p) – (non non possibilmente dio non crea p, da 6 per introduzione di doppia negazione; introduciamo una doppia negazione (che è uguale ad affermare) davanti alla formula precedente, puro cambio sintattico che non inficia il valore di verità, stiamo cioè riscrivendo la formula precedente in un altro modo)
- ¬□Crea(d,p) – (non necessariamente dio crea p, da 7 per equivalenza tra ¬◇¬ e □; altro cambio puramente sintattico, stiamo riscrivendo ulteriormente la formula precedente in altro modo, in questo caso si usa l’uguaglianza tra “non è possibile che non” e “necessariamente”)
- □Soffre(p)→□Crea(d,p) – (* se necessariamente p soffre, allora necessariamente dio ha creato p, da 4 per eliminaz. del quantificatore universale su y*; dato che non esiste alcun altro creatore per ogni persona, questo varrà anche per la persona p, quindi se necessariamente p soffre, è dio che l’ha necessariamente creato)
- ¬□Soffre(p) – (non necessariamente p soffre, da 4,5 per modus tollens; il modus tollens è una regola per la quale se si nega la conclusione di una implicazione, se ne deduce la negazione della premessa, in questo caso visto che prima abbiamo stabilito che non necessariamente dio crea p, e che se p soffre necessariamente allora dio lo crea necessariamente, concludiamo che non è necessario p soffra)
- ¬◇¬Soffre(p) → □Soffre(p) – (se non è possibile che p non soffre allora necessariamente p soffre, da 3 eliminaz. quantificatore universale su y; anche qui prendiamo un’affermazione valida per ogni persona e facciamo il caso particolare per p)
- ¬¬◇¬Soffre(p) – (non non è possibile che p non soffra, da 6,7 per modus tollens; come prima applichiamo il modus tollens, dato che non è necessario p soffra e che questo è implicato dal non essere possibile che non soffra, concludiamo la negazione di questa premessa)
- ◇¬Soffre(p) – (possibilmente p non soffre, da 8 per eliminaz. doppia negazione; riscriviamo la formula precedente in un altro modo, dato che all’inizio ci sono due negazioni, queste si eliminano perché la doppia negazione equivale ad affermazione)
- O(d) → ◇¬Soffre(p) – (se dio è onnipotente allora è possibile che p non soffra, da 1,9 per teorema di deduzione; quello che stavamo cercando di dimostrare è una implicazione, un nesso tra due proposizioni, proposizioni che abbiamo dedotto l’una dall’altra col supporto di alcune premesse ausiliarie, questo vuol dire che a meno di negare queste premesse, l’implicazione è dimostrata)
- ∀y( O(d)→ ◇( ¬Soffre(y) ) ) – (per ogni y se dio è onnipotente allora è possibile che y non soffra, da 10 per generalizzazione universale; qui passiamo a generalizzare la dimostrazione appena fatta, dato che come si è fatta per p si poteva fare per qualsiasi altra persona, allora possiamo dire che vale per ogni persona)
- ∀x∀y( O(x)→ ◇( ¬Soffre(y) ) ) – (per ogni y e ogni x se x è onnipotente allora è possibile che y non soffra, da 11 per generalizzazione universale; anche qui, la dimostrazione fatta per dio poteva essere fatta per ogni onnipotente, quindi possiamo dire che vale per ogni onnipotente)
Basata sulla facoltà di controllare i neurotrasmettitori del dolore
Data la possibilità neuroscientifica di non sentire dolore e i precedenti miracolistici/superstiziosi che vincolano il credente, possiamo anche avvalerci di questa versione.
Premesse:
- O(d)(dio è onnipotente; sub hypothesis, stiamo cercando di dimostrare che da questa premessa si arriva a una conclusione, quindi è assunto come premessa)
- ∀y( O(d) → ◇Anestetizza(d,y) )(per ogni y se d è onnipotente allora d puó impedire la sofferenza di y; premessa per cui un dio onnipotente ha la facoltá di alterare il moto dei neurotrasmettitori del dolore e impedire che arrivino alla sinapsi)
- ∀x∀y(◇Anestetizza(x,y) → ◇¬Soffre(y) )(per ogni x e y, se è possibile che un x impedisca a y di soffrire, è possibile per y non soffrire; ovvero ribadiamo l’ovvio, che se qualcuno puó impedire a y di soffrire, allora quel y puó non soffrire)
Deduzioni:
- O(d) → ◇Anestetizza(d,p)(se dio è onnipotente, allora dio può impedire a p di soffrire, da 2 per eliminazione del quantificatore universale su y; avendo detto che dio puó impedire la sofferenza di chiunque lo diciamo anche di p in particolare)
- ◇Anestetizza(d,p)(dio puó impedire a p di soffrire, da 1,4 per modus ponens; se dio è onnipotente e se è vero che il suo essere onnipotente implica che dio potrebbe impedire a p di soffrire, allora dio potrebbe impedire a p di soffrire, semplice applicazione dell’implicazione logica)
- ∀y(◇Anestetizza(d,y) → ◇¬Soffre(y) )(per ogni y se è possibile che dio impedisca a y di soffrire, è possibile che y non soffra da 3 per eliminaz. quantificatore universale su x; quel che abbiamo detto di ogni x lo diciamo anche di dio, per quanto riguarda gli effetti dell’impedire a qualcuno di soffrire)
- ◇Anestetizza(d,p) → ◇¬Soffre(p) )(se è possibile che dio impedisca a p di soffrire, è possibile che p non soffra, da 6 per eliminaz. del quantificatore universale su y; anche qui stiamo applicando un’affermazione generale a un caso specifico, ovvero che se dio puó impedire la sofferenza di qualcuno e questo rende possibile la sua non sofferenza, ció deve valere anche per p)
- ◇¬Soffre(p)(è possibile che p non soffra, da 5,7 per modus ponens; avendo stabilito la possibilitá di dio di impedire la sofferenza di p e che questa implica la possibile non sofferenza di p, concludiamo la possibile non sofferenza di p)
- ◇∀y( ¬Soffre(y) )(è possibile che per ogni y che y non soffra, da 8 per generalizzazione universale; qui passiamo a generalizzare la dimostrazione appena fatta, dato che come si è fatta per p si poteva fare per qualsiasi altra persona, allora possiamo dire che vale per ogni persona)
- O(d) → ◇∀y( ¬Soffre(y) ) (se dio è onnipotente è possibile che per ogni y questo non soffra, da 1,9 per teorema di deduzione; avendo dimostrato la precedente a partire dall’ipotesi che dio sia onnipotente, esplicitiamo questo nesso deduttivo)
- ∀x∀y( O(x)→ ◇( ¬Soffre(y) ) ) (per ogni y e ogni x se x è onnipotente allora è possibile che y non soffra, da 10 per generalizzazione universale; anche qui, se la precedente è valida per dio possiamo dimostrarla per ogni altro onnipotente, quindi generalizziamo a tutti gli dei)
Benevolo, indifferente o sadico

E infine ecco una dimostrazione della prima premessa, quella che forse è la più contenziosa per gli apologeti, per quanto essa sia invece ovvia banalità per il credente medio. Ovvero che se dio può non far soffrire una persona sceglierà di farlo, a parità di tutto il resto. Questo si comunica, tra le altre cose, quando si dice che “dio ci ama”. Se si intende altro ma si usa quella frase, si cerca consapevolmente l’equivoco e questa è una forma d’inganno.
Per dimostrare questo partiamo dal concetto di minimizzazione della sofferenza, ovvero che dati tutti gli stati che sono possibili a dio con le sue facoltà e che differiscono esclusivamente per la quantità di sofferenza presente, dio renderà reale quello con la sofferenza minima.
O in altre parole torniamo alla distinzione fatta nel paragrafo “Perché dio ti ama non-consensualmente” e definiamo:
- benevolente un dio che vuole meno sofferenza possibile e agisce in questo senso
- indifferente uno che non agisce a riguardo
- malevolo un dio che fa il possibile per aumentarla
Se un credente vuol dirci che il suo dio è sadico, malevolo, indifferente al dolore umano, ben venga, avrà comunque negato l’esistenza di un dio onnibenevolente come quello di cui parla questa dimostrazione.
E sia chiaro che tra gli indifferenti troviamo anche il dio masochista, il quale non solo non opera per ridurre la sofferenza umana, ma aumenta la propria rendendosene partecipe per scelta. Tipo facendosi frustare e crocifiggere.
- ∀x( MinimizzaSofferenza(x)→ ( ◇∀y(¬Soffre(y))→□∀y(¬Soffre(y)) ) ) – (per ogni x se x minimizza la sofferenza allora se è possibile che per ogni y questo non soffra allora necessariamente per ogni y questo non soffre; basilare implicazione della definizione di minimizzatore di sofferenza, asserisce che per ogni minimizzatore della sofferenza, questo renderà necessariamente vero il possibile non soffrire di una qualsiasi persona)
- ∀x( AL(x) ∧ O(x) → MinimizzaSofferenza(x) ) – (per ogni x se x è onnibenevolente e onnipotente allora x minimizza la sofferenza; basilare implicazione della combinazione di onnibenevolenza e onnipotenza, che queste rendano chiunque goda di entrambe le proprietà un minimizzatore della sofferenza)
- AL(d) ∧ O(d) ∧ ◇∀y(¬Soffre(y)) – (dio è onnibenevolente ed è possibile che per ogni y questo non abbia esperito sofferenza; sub hypothesis, stiamo cercando di dimostrare che da questa premessa si arriva a una conclusione, quindi è assunto come premessa)
- MinimizzaSofferenza(d)→ ( ◇∀y(¬Soffre(y))→□∀y(¬Soffre(y)) ) – (se dio minimizza la sofferenza, allora se è possibile per ogni y che y non soffra ciò implica che necessariamente ogni y non soffra, da 1 per eliminaz. quantificatore universale su x; se la prima premessa vale per ogni entità varrà anche per dio)
- AL(d) ∧ O(d) → MinimizzaSofferenza(d) – (se dio è onnibenevolente e onnipotente, allora dio minimizza la sofferenza, da 2 per eliminaz. quantificatore universale su x; se la seconda premessa vale per ogni entità varrà anche per dio)
- AL(d) ∧ O(d) – (dio è onnipotente e onnibenevolente, da 3 per eliminaz. della congiunzione; se sono vere tutte e tre le proposizioni della terza premessa, saranno vere anche le prime due prese da sole)
- ◇∀y(¬Soffre(y)) – (è possibile che per ogni y questo non soffra, da 3 per eliminaz. della congiunzione; se sono vere tutte e tre le proposizioni della terza premessa, sarà vera anche la prima presa da sola)
- MinimizzaSofferenza(d) – (dio minimizza la sofferenza, da 5,6 per modus ponens; se l’onnipotenza e onnibenevolenza di dio ne implicano la minimizzazione della sofferenza e se questo è onnipotente e onnibenevolente, allora deduciamo che dio minimizza la sofferenza)
- ◇∀y(¬Soffre(y))→□∀y(¬Soffre(y)) – (se possibilmente per ogni y questo non soffre allora necessariamente per ogni y questo non soffre, da 4,8 per modus ponens; anche qui deduciamo da un’implicazione e la verità della premessa la conclusione, arrivando ad affermare che la possibilità di non soffrire ne implica la necessità alle condizioni in cui siamo a questo punto)
- □∀y(¬Soffre(y)) – (necessariamente per ogni y questo non soffre, da 7,9 per modus ponens; dato che avevamo anche già stabilito che la non sofferenza è possibile per ogni y, vista l’ultima implicazione, concludiamo la necessità della sua non sofferenza)
- AL(d) ∧ O(d) ∧ ◇∀y(¬Soffre(y)) → □∀y(¬Soffre(y)) – (se dio è onnibenevolente e onnipotente e se è possibile per ogni y che questo non soffra, allora è necessario che questo non soffra, da 3,10 per teorema di deduzione; a questo punto possiamo arrivare a stabilire l’implicazione che volevamo dimostrare, essendo entrambe state dimostrate in questa catena logica, ovvero che c’è un nesso di implicazione tra onnibenevolenza, onnipotenza, possibile non sofferenza da un lato e necessaria non sofferenza dall’altro)
- ∀x( AL(x) ∧ O(x) ∧ ◇∀y(¬Soffre(y)) → □∀y(¬Soffre(y)) ) – (per ogni x se questo è onnibenevolente e onnipotente ed è possibile per ogni y non soffrire, necessariamente per ogni y questo non soffre, da 11 per generalizzazione universale; quel che abbiamo dimostrato per dio, vale per ogni divinità onnibenevolente e onnipotente, quindi generalizziamo la formula)
Nota tecnica: la dimostrazione vale tal quale se si prepone □ alla proposizione Minimizza Sofferenza, quindi anche nel caso si volesse interpretare la necessarietà in senso metafisico e non semplicemente di possibilità, l’asserto è egualmente dimostrato.
Cosa potrebbe un disperato teista a questo punto cercare di attaccare in questa dimostrazione? Difficilmente potrà attaccare la prima premessa, che è un ovvio effetto della definizione di minimizzatore di sofferenza, sicuramente non la terza perché è assunta per ipotesi al mero scopo di dimostrare che tra le sue implicazioni troviamo qualcosa. Rimane solo la seconda, la quale esplicita il passaggio da volontà ad atto; ma per negare quella dovrebbe asserire che sia possibile a dio volere e potere qualcosa ma non farla. Questo andrebbe in altre parole a negare il concetto stesso di volere quel qualcosa, oltre a svuotare di ogni significato tutte le espressioni del tipo “è così perché dio l’ha voluto”, presenti un po’ ovunque nelle varie religioni.
Quel che resta delle teodicee

Come si misurano le solite manfrine apologetiche contro questo problema del male?
Abbiamo già visto come la dottrina del duplice effetto e tutte le teodicee dei beni superiori non possano rispondere a questa: non c’è nessun effetto o causa che richieda necessariamente la sofferenza.
Neppure il mistero della fede richiesto dal libro di Giobbe trova spazio: noi sappiamo che la sofferenza non è necessaria a qualsiasi altro possibile scopo divino.
Non c’è neppure libero arbitrio che tenga: la libertà di ferire il prossimo non è inficiata dal suo non patire coscientemente per la ferita (e per inciso, per citare “the messian manic”, il mio libero arbitrio sceglie l’infallibilità morale invece della libertà, perché non posso averla?).
Non tiene neanche la teodicea della giustizia contro i peccati: soffrono anche i neonati appena battezzati, soffrono i penitenti appena confessati e comunicati, soffrono gli innocenti in ogni forma e luogo.
Che ne è poi delle teodicee che vedono la sofferenza come uno strumento di prova o di edificazione dell’anima?
In primis, quelle erano già insostenibili da quando Skinner ha dimostrato che il piacere è ben più utile come strumento di insegnamento rispetto al dolore (approfondimento qui) e ancor più se uno nega l’identità mente-cervello sostenendo l’esistenza di un’anima: non c’è motivo alcuno per cui l’anima debba necessitare questa o quella percezione per apprendere.
In secondo luogo, come abbiamo già detto nessun effetto richiede necessariamente la sofferenza come causa. Quei neuroni che potevano essere attivati dal segnale della sofferenza, dio può tranquillamente attivarli spostando qualche ione. Provocando gli stessi apprendimenti e le stesse reazioni.
E le teodicee agostiniane? Quelle in cui essenzialmente si nega l’esistenza stessa del male? Non possiamo negare l’esistenza della sofferenza, quindi bisognerebbe affermare che la sofferenza non sia male, in altre parole che dio sia indifferente alla sofferenza. E quindi l’inesistenza di un dio benevolo e amorevole.
Ireneo proponeva il male come misura necessaria della distanza da dio, una sorta di componente intrinseca della separazione da esso. Eppure questa separazione non necessita la sofferenza, come dimostra l’esistenza di ogni sorta di atei e satanisti che non soffrono. Ma fosse anche quello il caso, dovremmo credere che senza soffrire si è uniti a dio e quindi che ogni umano non sofferente gode della piena presenza di dio quando non soffre. I risvolti teologici di questa posizione diventano assai comici quando si considerano anche gli effetti antidolorifici di farmaci e droghe.
Che dire delle promesse di una redenzione futura, di una gioia tale da controbilanciare la sofferenza presente? Semplicemente che un dio benevolo darebbe queste grazie senza intanto infliggerci la sofferenza.
E la “teodicea della croce”, in cui si risponde che dio soffre con noi? Questa dipinge dio come un masochista sadico o indifferente, ma non benevolo. Semplicemente non risponde del problema ma lo aggrava.

Che ne è di Leibnitz e del suo migliore dei mondi possibili? Beh, le neuroscienze ci dimostrano che il migliore dei mondi possibili non ha sofferenza alcuna, a parità di tutto il resto, quindi non è certo quello in cui ci troviamo.
Le teologie del “contrasto”? Quelle che sostengono che senza il male non riconosceremmo il bene, pure sembrano implicare che senza sofferenza non riconosceremmo il piacere. Tuttavia le neuroscienze ci dicono che sono semplicemente segnali differenti e che la neutralità è sufficiente a discriminarli. Inoltre sarebbe come dire che senza morderci la lingua ogni tanto non riusciremmo ad assaporare un dolce. L’esperienza di ognuno di noi dimostra il contrario.
Arriviamo quindi alle “teodicee” più estrose, quelle che neanche provano a difendere dio.
Da un lato abbiamo la teodicea karmica di origine induista, quella per cui la sofferenza è giustificata dalle colpe di vite passate. Questo però presuppone che la sofferenza sia l’effettivo scopo, non un qualcosa di incidentale. In altre parole che l’ente divino che plasma la realtà voglia proprio infliggere sofferenza a chi ha avuto comportamenti in una vita passata che giudica meritevoli di questo trattamento. In altre parole si tratta di un ente sadico, quindi certamente non un dio onnibenevolente.
Da un altro troviamo la teodicea di Davies, secondo la quale dio è dio, e noi non siamo un cazzo, quindi le categorie morali a dio sarebbero inapplicabili. In primis questo semplicemente accorcia la dimostrazione: un dio del genere non è buono e non è amorevole, insomma il dio descritto dal credo cattolico, dalla Bibbia e dalla maggioranza dei credenti non esiste in presenza di un dio del genere.
Ma in secondo luogo questa dimostrazione non è minimamente inficiata perché non ha fatto uso delle categorie morali di buono o malvagio in primo luogo. Ha fatto uso solo del concetto di “volere il benessere” degli umani. Che questa caratteristica si qualifichi come buona o malvagia per il soggetto che la possiede, è irrilevante, quindi anche questa teodicea non risolve il problema.
Infine troviamo la risposta islamica per cui la vita sarebbe una prova a cui le singole anime individualmente danno consenso prima di entrarvi. Ci sarebbe probabilmente da scrivere parecchio solo per elencare tutti i problemi di questa risposta, quindi mi limiterò a quel che è pertinente a questa dimostrazione: anche accusando l’anima stessa di masochismo, non si escluderebbe dio dalle sue responsabilità, quel dio comunque è nella condizione di mettere l’umano alla prova senza far uso di sofferenza.
O Auschwitz o dio

In sintesi, abbiamo visto come la sofferenza non possa coesistere con un dio capace di soffiar via qualche molecola o di evitare di creare l’universo, e interessato anche solo minimamente al benessere umano.
Un tale essere potrebbe, senza alcun costo in termini di risultato, eliminare ogni sofferenza dall’universo.
Un tale essere vorrebbe farlo.
Se un tale essere esistesse, non esisterebbe sofferenza alcuna.
Abbiamo dimostrato che il dio abramitico ha questi attributi nelle dottrine e nei testi sacri rilevanti, abbiamo dimostrato logicamente la loro incompatibilità. Abbiamo visto anche come nessuna delle teodicee proposte fino a oggi può rispondere di questa dimostrazione e che non resta spazio nemmeno al mistero della fede per chi vuol tenersi il suo dio.
Razionalmente quindi non resta altra possibilità che affermare con certezza e convinzione che il dio buono e onnipotente non esiste.
Come Volevasi Dimostrare.


Caro Faber, complimenti per l’articolo, come sempre frutto di conoscenze, approfondimenti, riflessioni.
Non sono d’accordo quando dici che questo presunto dio dovrebbe chiederci l’autorizzazione a farci soffrire. Mettiamo in moto la fantasia e facciamo finta che un tale dio come quello abramitico esista. Un padre, dicono, che sa tutto e vuole il bene dei suoi figlioli. Ok. (ma poi, perché non “madre” o semplicemente “genitore”?) Comunque, se tu sai (perché sai tutto, sei dio…) che il tuo bambino di 3 anni avrà salva la vita con una certa operazione dolorosa e per l’appunto non c’è anestesia, non tenti il tutto per tutto? Vero, non consensuale, ma sempre amore è. E il permesso non glielo chiedi, no che non glielo chiedi. Diciamo che, essendo onnipotente avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato in altro modo, ma questo è un altro problema, e non da poco. Comunque no, questo dio non dovrebbe chiedere a noi il consenso, se sa che quello è l’unico modo per raggiungere il bene. Resta, ripeto, il grosso problema che QUELLO sia l’unica via percorribile, perché così cade l’attributo dell’onnipotenza. Se tuo figlio è grande, magari adulto, potrebbe anche scegliere di morire. Ma secondo la religione cattolica noi siamo come bimbi piccini di fronte a questo dio che più che onniPOTENTE sembra prePOTENTE.
Grazie del commento… e del supporto, in generale.
Per rispondere nel merito, questo tipo di discorso presuppone qualcosa di contrario alla dottrina cattolica e ai fondamenti del cattolicesimo: che l’uomo non abbia conoscenza del bene e del male. Ovvero che debba essere accudito da un tutore che sceglie in sua vece perché incapace di intendere e di volere, ma questo puó avvenire solo e soltanto al prezzo di non essere ritenuti responsabili delle proprie azioni. Oltre a questo, anche nel caso del bambino, il genitore tenta di spiegare la questione in termini comprensibili al bambino anche laddove il suo consenso non é richiesto. A 3 anni sará al piú “adesso bua cosí dopo stai meglio”, ma il buon genitore lo fa per minimizzare la sofferenza non aggiungendovi la confusione e la paura al dolore. Quindi per tutti questi motivi l’analogia si rompe e resta inapplicabile al problema della sofferenza.